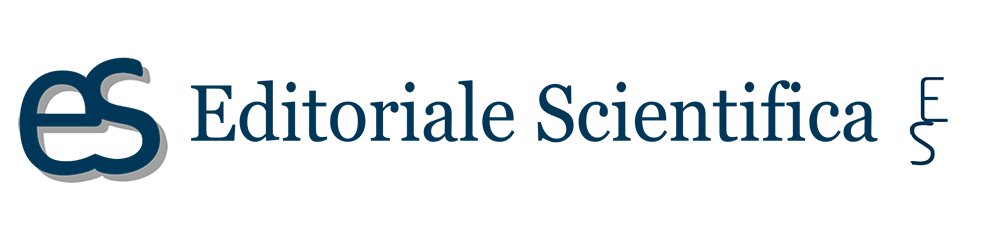30 Gennaio 2025 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nel Caso “Cannavacciuolo e a. c. Italia”, ha condannato l’Italia per non aver adeguatamente protetto la salute dei cittadini residenti nella Terra dei Fuochi. In particolare, la Corte ha ritenuto che l’Italia abbia violato l’articolo 2 della Convenzione Europea, che tutela il diritto alla vita. Si ricordi che per “Terra dei fuochi” si intende un’area geografica che si estende tra Napoli e Caserta devastata da anni dall’inquinamento dovuto a ripetuti smaltimenti illeciti di rifiuti tossici.
Questa sentenza mette in luce la necessità di un intervento coordinato ed efficace e solleva interrogativi sul sistema normativo nazionale relativo alla gestione di siti contaminati. In Italia, tale materia è regolata principalmente dal Decreto Legislativo 152/2006, meglio noto come “Codice dell’Ambiente”. Nella Parte IV, Titolo V, il Decreto disciplina le procedure di bonifica dei siti inquinati, stabilendo che chiunque abbia causato l’inquinamento sia responsabile della messa in sicurezza e della bonifica, in linea con il principio “chi inquina paga”. Ma cosa succede quando il soggetto responsabile non è identificabile? In questo caso spetta allo Stato, attraverso le autorità competenti, farsi carico degli interventi necessari.
Nonostante la normativa preveda un ruolo attivo dello Stato nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica, in Italia il Caso della Terra dei Fuochi, in cui la protezione statale è risultata inefficiente, non è isolato. Un altro esempio emblematico è quello della Valle del Sacco, un’area compresa tra le province di Roma e Frosinone, che prende il nome dal fiume che la attraversa. Questa zona dal 2016 è stata classificata come Sito di Interesse Nazionale (SIN) per la bonifica ambientale a causa dell’inquinamento dovuto dal beta-esaclorocicloesano, un pesticida tossico rilasciato dalle industrie locali a partire dagli anni ’60. Malgrado i fondi pubblici stanziati, le operazioni di bonifica di quest’area proseguono a rilento, lasciando la popolazione esposta a gravi rischi sanitari. Diversi studi condotti nell’ambito del Progetto “INDACO” (Progetto di ricerca – Indagine Coorte Nati SIN Valle del Sacco), dedicato all’analisi epidemiologica del SIN Valle del Sacco, confermano infatti gli effetti negativi dell’inquinamento sulla salute dei residenti.
Anche in questo caso emerge chiaramente come il nodo cruciale sia rappresentato dalla responsabilità delle istituzioni. Le difficoltà nell’attuazione degli interventi programmati e la mancanza di un controllo efficace evidenziano una gestione pubblica inefficiente. Un’eventuale risposta inadeguata nell’adempimento degli obblighi stabiliti dalle normative italiane e internazionali potrebbe, come già accaduto per la Terra dei Fuochi, portare a nuove condanne da parte della Corte di Strasburgo. Ed è proprio per evitare ciò che la CEDU, nella già citata sentenza del 30 Gennaio 2025, ha sollecitato le autorità italiane 1) ad adottare un piano d’azione più organico, capace di integrare le misure già esistenti con strategie future e 2) garantire una netta e funzionale ripartizione delle competenze tra i diversi livelli dell’amministrazione. L’obiettivo è evitare quella “inutile frammentazione delle responsabilità” che fino ad oggi ha ostacolato un’efficace risposta ai gravi problemi ambientali presenti sul territorio.
Elisa Marcoccia