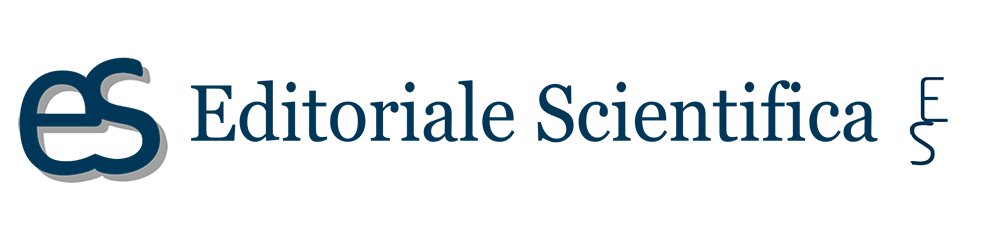A Chittagong, una delle principali città portuali del Bangladesh, si registra da anni una grave crisi ambientale legata allo smaltimento delle grandi navi. La città ospita il secondo cantiere navale al mondo per dimensioni, dove vengono demolite numerose imbarcazioni a fine vita.
Il processo di smantellamento solleva forti preoccupazioni: le condizioni di lavoro sono spesso precarie e l’impatto ambientale è devastante. La tecnica più usata è il beaching, che consiste nel far arenare le navi sulla spiaggia per smantellarle. Questa pratica libera in mare sostanze tossiche non recuperabili. Le navi dismesse contengono materiali di valore, come acciaio e rame, ma anche sostanze pericolose come amianto, PCB, idrocarburi, metalli pesanti e olii residui. Questi rifiuti, che dovrebbero essere trattati in impianti specializzati, vengono spesso gestiti in modo improprio per risparmiare sui costi.
Da un punto di vista normativo, la Convenzione di Basilea (1989), ratificata da oltre 180 Paesi incluso il Bangladesh, regola i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, inclusi quelli derivanti dalle navi. Pur non citandole espressamente, le navi rientrano nelle categorie di rifiuti regolati dalla stessa, a causa dei materiali pericolosi che contengono. A livello generale, si ricordi che la Convenzione impone standards ambientali per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, limitando pratiche come il beaching, che avvengono senza l’utilizzo di strutture e/o protezioni adeguate.
Per rafforzare questa Convenzione, nel 1995 è stato introdotto il Ban Amendment, entrato in vigore nel 2019. Questo emendamento vieta l’esportazione di rifiuti pericolosi dai Paesi OCSE verso gli altri Paesi, a meno che questi ultimi dimostrino di poterli gestire in sicurezza. Nel caso di specie, questo emendamento rende di fatto illegale smantellare le navi nei Paesi in via di sviluppo se contengono materiali pericolosi.
In questo contesto, particolarmente interessante è la Convenzione di Hong Kong adottata dall’IMO nel 2009. La Convenzione, che garantisce una demolizione sicura delle navi, tutelando ambiente e lavoratori, mira a migliorare i cantieri esistenti e impone alle navi l’obbligo di un inventario dei materiali pericolosi. A differenza della Convenzione di Basilea, quindi, la Convenzione IMO non vieta il beaching purché i cantieri rispettino gli standards minimi. La Convenzione è entrata in vigore il 26 giugno 2025, dopo la ratifica di Bangladesh e India. Si ricordi che L’IMO ha avviato, inoltre, progetti di supporto con il Bangladesh per migliorare gli standard ambientali (SENSREC).
Tuttavia, molti armatori riescono ad aggirare la normativa esistente. Una pratica diffusa è il flag hopping: cambiano la bandiera della nave poco prima della demolizione, passando da un Paese OCSE a uno non OCSE. Altri fingono che la nave sia destinata a riparazioni o trasporti, per raggiungere liberamente i cantieri.
Secondo il Global Shipbreaking Report pubblicato dalla NGO Shipbreaking Platform, il Bangladesh nel 2024 ha demolito, senza misure di sicurezza adeguate, 130 navi, pari al 42% del tonnellaggio globale. Si ricordi che ogni nave può contenere tra le 10 e le 100 tonnellate di vernici tossiche (sono composte da piombo, cadmio, arsenico, cromo) e fino a 1.000 m³ di olio residuo. Queste sostanze inquinano il mare e le spiagge, alterano l’equilibrio chimico dell’acqua e danneggiano gravemente l’ecosistema costiero, minacciando la biodiversità.
Il costo umano è altrettanto drammatico: migliaia di lavoratori, inclusi migranti e bambini, smontano le navi a mano, spesso senza protezioni. Dal 2009 si contano almeno 470 morti per incidente nei cantieri dell’Asia meridionale. Senza dimenticare che i rischi sanitari sono altissimi, con frequenti esposizioni a sostanze cancerogene come l’amianto.
La demolizione navale a Chittagong mostra come il profitto prevalga su ambiente e diritti umani. Costi bassi e controlli carenti permettono di eludere le normative, favorendo armatori e autorità locali. Nonostante l’esistenza di convenzioni internazionali pensate per regolamentare il settore, la realtà mostra che siamo ancora ben lontani dal garantire standard adeguati sul piano ambientale, sociale e normativo in questo settore.
di Giovanni D’Ascenzi